Alla notizia della scomparsa di Bachisio Zizi (avvenuta la settimana scorsa a Cagliari) anch’io ho sollecitato lo studioso Gianfranco Murtas a condividere la sua amicizia con lo scrittore nuorese con una platea la più ampia possibile. Così è nato questo intervento, di cui qui trovate una ampia sintesi di un contributo già fornito alla Fondazione Sardinia: sintesi tutta centrata su quegli aspetti biografici che si pongono al fondo ispirativo della produzione letteraria di Zizi.
***
«Bisogna onorare Bachisio Zizi», mi hanno detto in molti in questi giorni, e me ne hanno dato l’incarico (e direi l’onore davvero tante volte più dell’onere). Certo è stato così a motivo di quelle relazioni professionali continuative di lunghi anni, ora nella sede solenne del largo Carlo Felice ora in quella non meno prestigiosa di piazza Deffenu. E per quelle altre letterarie, della libera passione per la scrittura, vocazione realizzatasi in Lui da maestro. Per avergli fatto da lettore in anteprima – lettore critico, come desiderava, sui soggetti e sulle virgole (ne era parsimonioso) – e anche correttore di bozze, dopo il lungo stacco da “Greggi d’ira”: quasi un decennio per ricominciare con “Il ponte di Marreri”, nel 1981.
Sì, per la banca e per la letteratura, simbiosi originale ch’Egli ha declinato lasciandone traccia riconoscibile e importante. E anche per quanto è seguito all’assorbimento, villano e sgradevole nei modi (tanto più nell’Isola), del Banco di Napoli nel Sanpaolo – avvenuto fortunatamente dopo il suo passaggio in quiescenza –, e per quanto e per come ha quindi accompagnato il tentativo di ricostruzione della storia onorata dell’Istituto in oltre un secolo di vita civile ed economica a Cagliari e in Sardegna, proprio come avviene nell’elaborazione di un lutto privato, per dirci che il morto non è morto ma vive in noi che rimaniamo e nell’aria, nei colori e negli umori del mondo: storia di una corposa comunità aziendale dentro la più larga storia sociale di città e paesi (i capoluoghi ma anche Villacidro e Arbus, Tempio ed Olbia, Bitti e Sorgono, Lanusei e Siniscola, e moltiplica tutto per tre…).
E qui debbo, di necessità, una precisazione o chiamalo avvertimento. Intendendo io offrire al presente testo il senso e il taglio di una testimonianza, non riconoscendomi altro abito per intervenire in questo domani afflitto, capiterà che offrendo pagine ziziane, anche private quando utili alla rappresentazione della ricchezza della sua anima, oltre che del suo ingegno e del suo sapere, debba svelare aspetti meritevoli forse soltanto di una memoria personale. Perché si mostrano elogiativi, direi incongruamente elogiativi, della mia lealtà e prossimità a Lui. Ma dopo averci molto pensato ho accettato di pagare questo prezzo, a costo di qualche inevitabile, e certo rispettabile, incomprensione.
La banca come i novissimi della teologia
Mi accingo dunque a questa laica celebrazione, in un andirivieni di emozioni, ricordi e riflessioni, in cui Lui non è, non diventa e non può diventare il santo da mettere nella nicchia, pietrificato in virtù astratte, letterarie nel senso meno nobile del termine, ma l’uomo che abbiamo, che ho frequentato quotidianamente per molti anni, con il quale ho discusso e sono entrato in confidenza, verso cui sono poi caduto (ricambiato) in sorda diffidenza, e ancora dopo sono tornato in amore.
Tutto ritorna nella memoria e nel sentimento oggi, come si trattasse della grande tela di un impressionista: l’ufficio, quello operativo della capogruppo interprovinciale Cagliari-Oristano e poi quello regionale, programmatorio, ispettivo e di amministrazione degli alti rischi, le pratiche dell’ufficio legale e quelle dell’articolato ufficio fidi (i famosi “settori”), i rituali pomeridiani della concessione delle eccedenze sugli accordati – e se ci capitavi, ora interlocutore ora spettatore, comprendevi ogni volta dai suoi ragionamenti lo stato di salute, per check up istantaneo, di quel certo cliente in tensione e comprendevi le tendenze dell’economia del pianeta intero – , e ancora i concorsi ch’egli presiedeva, primo in commissione perché il più autorevole e il più competente fra i dodicimila dell’organico plenario e anche fra i cento dei vertici selezionati: competente come un professore d’università, fra azienda bancaria e diritto societario e familiare, amministrativo e fallimentare, fra scienza delle finanze, ragioneria ed arte – soprattutto arte, l’arte che non è però dei professori universitari – di dar credito a chi lo merita, agli “uomini del fare”… anche oltre i parametri apparentemente virtuosi della matematica.
Agli “uomini del fare” di cui ha scritto, e scritto molto, in pagine limpide dapprima per i giornali poi per i libri. (Questo della collaborazione con i giornali era stato uno degli argomenti che avevo discusso con lui quando l’incontrai per la prima volta, nell’estate 1976: in banca ma non per parlare di banca, ma appunto di giornali, e di libri, e di repubblicani amici comuni, e di Nuoro. Gliela avevo sparata così, rientrava nelle sue corde, a mio parere. Se avesse voluto avrei potuto anche favorirla, allora, quella collaborazione a “L’Unione Sarda” o a “La Nuova Sardegna”. Sarebbero passati alcuni anni e la collaborazione, non con la mia mediazione, venne davvero, e con una testata e con l’altra).
Nuoro amore nostro
Le pagine della migliore narrativa di Bachisio Zizi sono tutte centrate sull’umanità che Egli meglio conosceva, radicata nel cuore della Sardegna: quell’umanità che sapeva molto delle regole sociali non scritte e molto aveva dato all’ispirazione un tempo della Deledda o di un Sebastiano Satta e anche dei grandi poeti in limba, che aveva donato suggestioni creative a un Ciusa, un Delitala, un Ballero, e passione democratica (oltreché genio professionale) a un Mastino, un Oggiano, un Pinna… L’arte della sua scrittura – questo mi diceva Lui ma per esaltare il modello e specularmente sminuire (modestamente, ingiustamente e, nel caso, neppure sinceramente) il suo talento – affondava nella cultura dei pastori che vivendo per lunghi mesi lontano dal paese elaboravano fantasticamente il possibile reale delle loro donne, delle loro famiglie, delle relazioni ora crude ora d’alleanza, mai banali, in Barbagia… e tessevano atmosfere che erano il respiro delle metafore, di quelle rappresentazioni vitali in cui essi mettevano gli abiti alla natura, alle stagioni, alla luna e alle bestie…
La nettezza amara di talune figurazioni, talvolta fisiche e più spesso intime, anzi intimistiche, era entrata più di recente – ma ormai è trascorso quasi mezzo secolo anche da questo “recente” – in rapporto di parentela, per intuizioni del vissuto nascosto dei protagonisti e certi ritmi impressi alla scrittura, con la produzione nientemeno che di Salvatore Satta. Del professor Satta, di quel suo conterraneo e docente di diritto processuale civile all’università di Genova frequentata per gli esami mentre attendeva, negli anni ’50, al suo ufficio nella succursale di Nuoro, al Corso. Materia di discussione frequente anche questa, per un lungo tempo, mia con Lui.
Il capolavoro di Salvatore Satta Egli era stato fra i primi, con il professor Fausto Satta, nipote del grande, a vederlo nella stesura originale, e su di esso era stato Lui con il professor Fausto Satta, ad intervenire, per l’edizione Adelphi, con quell’operazione di aggiustamento, nel rispetto delle assonanze, dei cognomi, per assorbire ogni possibile tensione o reazione delle cerchie domestiche di quegli attori richiamati dal non tempo, dalla dimenticanza come stato dell’anima, e convocati per ripetersi sulla scena terribile della vita nuorese: autentico e sterile, inutile scempio di cui essi avrebbero fatto colpa allo scrittore…
Vi sono pagine oniriche, tanto più in “Erthole”, che rimandano alla docenza morale e sociale dei pastori, ed altre piuttosto puntate sui profili – come quelle di “Santi di creta” (per le scene delle cui prime pagine mi chiese i materiali religiosi di compianto, e suffragio, del defunto) – in cui la ritmica e il cupio dissolvi sattiani si fanno più marcati, in cui Zizi offre qualcosa che è stato detto essere fra il più bello della nostra letteratura sarda del Novecento.
“Santi di creta” è il romanzo che, a mio parere – e gliel’ho sempre confidato, per bisogno mio di esternazione –, costituisce il vertice della sua fatica letteraria. Più del molto che è venuto dopo, e che pure forse stilisticamente rappresenta altri, ulteriori avanzamenti. Ma in “Santi di creta” c’è la vita, non “soprattutto” l’elaborazione della vita.
All’impero dei Guiso Gallisai Egli era giunto, per uscirne infine sconfitto, ancora ragazzo, dopo le fatiche della cava e quelle di Carbonia al suo esordio produttivo. E in quell’azienda – o in quel sistema di aziende, meglio – era cresciuto umanamente: forse cogliendone, naturalmente con gli strumenti cognitivi o interpretativi che i suoi quindici anni e il sapere dell’età oltre che la poca scuola potevano concedergli, i meccanismi contraddittori di una cultura industriale ancora precapitalistica, legata o impacciata dai lacci della responsabilità illimitata propri delle società di persone, che confonde impresa e famiglia, famiglia e impresa.
Ma discostandosene in età matura, facendosene analista più che giudice, amava – continuava ad amare! – quel mondo nuorese attardato sulla storia, lento sul calendario del vasto mondo (come avrebbe detto Gonario Pinna, caro a Zizi e caro a me), non lo giudicava selvaggio e meritevole di dileggio, al contrario, lo teneva caro per la sua contraddittoria umanità offrendo alla sua storia, e della sua storia, dopo il fallimento magno degli anni ’60, tutti i fotogrammi ordinati e commentati, spiegati, esaminati per il dritto e il rovescio…
Non fu capito, e patì un processo che per tre volte si concluse con una condanna per causa di letteratura, a nulla valendo, nonché l’abilità del difensore, i manifesti dei suoi colleghi narratori, degli intellettuali sardi, in testa mi pare di ricordare Mario Ciusa Romagna (il professore caro anche lui ad entrambi). Ne scrisse anche “la Repubblica”, il caso ebbe echi nazionali, la giustizia non onorò né le ragioni alte della libera civiltà repubblicana né se stessa. Oltre ad una cospicua ammenda la sentenza costrinse il riconosciuto “reo” al ritiro (invero impossibile) delle copie del libro ancora nei canali commerciali.
Quanta sofferenza! Ma la sofferenza più ancora che per l’inusitato processo e per il dispositivo della condanna, era per la incomprensione del suo testo, delle sue intenzioni, della sua buona fede. Circostanza che aveva coinvolto anche sua moglie, la professoressa Maria Baldessari, creatura raffinata di forte sentire civile – a scuola era stata fra le prime a portare le lettere dei condannati a morte della resistenza antifascista –, finissima scrittrice anche lei, un passo dietro Bachisio che soltanto dopo la sua morte, venuta dopo tanto travaglio, aveva dato alle stampe un bellissimo libro autobiografico – “La figlia della Taliana” – capace di illuminare squarci rilevanti della vita sociale di Nuoro negli anni del regime fino alla tragedia della seconda guerra mondiale. Perché anche lei era stata investita da una sommaria condanna emessa da singoli furenti ma espressa anche negli umori diffusi a Seuna e San Pietro, e attorno a Sant’Onofrio.
Aveva portato anche in televisione i suoi “Santi di creta”, Bachisio Zizi, realizzando lui stesso – lavoravamo entrambi allora (gratis naturalmente) nello stesso studio televisivo – un documentario molto bello che meriterebbe di essere ripresentato. La cui prima scena era nel cimitero di Nuoro, a Sa ‘e Manca, opera di quel don Gavino Gallisay – Minosse ne “Il giorno del giudizio” – che era stato molte cose nella Nuoro ottocentesca, comandante della squadriglia antibanditesca in surroga dei carabinieri e magna pars della loggia Eleonora al tempo dei moti di “su connottu”, amico ammirato di Giorgio Asproni e avversario tenace del vescovo carmelitano funzionario del papa-re che, dopo le glorie della Repubblica romana, aveva ripristinato la ghigliottina abolita da Mazzini…
Ne presi le difese – me ne resi conto allora (mosso dal senso del dovere) e me ne rendo conto ovviamente anche oggi, senza autorità particolare – in un articolo su “L’Unione Sarda”. Allora Egli – il direttore-romanziere – già aveva lasciato Cagliari e lavorava a Roma, dopo essersi anche fermato un anno o due in Direzione Generale come responsabile del Servizio Credito Fondiario, capo di qualche centinaia di filiali del Banco di Napoli nell’area centrale della penisola. Gradì la solidarietà del giovane amico, non importa se inefficace o non autorevole.
Ripenso a questo rapporto nostro fra banca e letteratura, ai suoi infortuni fisici non di breve momento, ai ricoveri, all’operazione agli occhi a Barcellona, che lo rivelavano nella disarmata povertà di una umanità per alcuni tratti riservata, orgogliosa e quasi scontrosa e per altri invece, e si direbbe incredibilmente, umile e propensa all’invocazione di un soccorso. Debbo ripeterlo: vien da pensare e ripensare, sopra ogni cosa, alla tribolata vicenda del processo per il suo bellissimo “Santi di creta”. Non capito neppure da chi pure aveva cultura e sensibilità per entrare in quei percorsi segreti, ispirativi della trama, e cogliervi nel sottotraccia il valore aggiunto.
Anche Elena Melis, carissima amica nuorese – donna di scuola e di impegno civile – con la quale discussi di quest’opera, faticava… E la sua limpida onestà che la portava a conclusioni opposte alle mie mi ha allora ed oggi spiegato perché i nuoresi hanno maltrattato la Deledda, o hanno faticato a riconoscere una borsa di studio a Francesco Ciusa adolescente, per i corsi fiorentini… Ma Nuoro è una città che Zizi aveva nel cuore come pochi: non soltanto Nuoro come territorio, Nuoro come comunità, Nuoro come gente, Nuoro come nuoresi, nella loro umanità complessa e complicata, talvolta o spesso incapace – per quella collocazione geografica che la natura aveva voluto così eccentrica – di gustare il relativo, il farsi tessera di un mosaico e non personificazione delle tavole della legge morale, del dogma del giusto vivere. Zizi, non solo Lui ma forse soprattutto Lui con Ottorino Pietro Alberti e Lello Puddu, anche a me ha insegnato ad amare Nuoro. Che bella conquista per un campidanese, per un cagliaritano!
I corsi delle età, i percorsi delle esperienze
Scrivo e mi sembra di non muovermi dalla stessa idea di fondo: Zizi ovvero la fatica del vivere, Zizi ovvero la santità del dovere, Zizi ovvero la macina e il miscelatore delle esperienze e l’interprete e il narratore (penna alla mano, ma poi quanto abile alla tastiera del personal computer!), Zizi ovvero l’analista amante delle sintesi, Zizi l’incantatore, l’obbediente del vocabolario, signore elegante nell’eloquio, disciplinato e misurato, preparato sempre, improvvisato mai.
Non il dottor Jekyll delle delibere di fido o dell’amministrazione prudente del rischio ed il (qui virtuoso) mr. Hyde delle espansioni letterarie, sia chiaro: l’unità coerente della persona era evidente, ed un terzo ipotetico che avesse potuto invadere la discrezione dei periodici incontri del superdirettore con i collaboratori capi di filiale territoriale o funzionari preposti ai servizi della capogruppo ed avesse quindi assistito a un dibattito letterario o ad una intervista a tutto campo sul pretesto di un libro fresco di stampa, se ne sarebbe fatto testimone.
Vi avrebbe trovato la stessa intelligenza nel definire il mix di analisi e sintesi – vocazione permanente in Bachisio Zizi uomo, banchiere e scrittore –, la stessa modalità anche d’interrogazione ai suoi collaboratori (e/o ai clienti del suo Banco) come ai suoi personaggi –, la stessa tensione a cogliere l’“oltre”, il non palese ma pur reale, deposito ora di esperienze da valorizzare ora di opportunità nuove da cogliere e sostenere: sì, quell’ “oltre” presente nelle pagine di “Erthole”, che pare il luogo in cui il visibile altera sovente, e confonde per un paradossale rovescio di mimesi, le sue forme e l’invisibile avverte della sua esistenza reclamando talvolta, o spesso, riconoscimento.
Veramente come nel suo ufficio – nel Largo cagliaritano od a palazzo Tirso – alle assemblee dei capi, lui presidente per aprire e concludere, per informare e promettere, per domandare ed ammonire, per sollecitare e suggerire ed anche pretendere… Forse non sempre a ragione, ma certo con argomenti sempre sodi e intuiti per degni. Per l’impostazione, o negoziazione, degli obiettivi, non soltanto di quantità, e per la verifica dei risultati rispetto ai target – sostantivo affermatosi nel linguaggio economico globalizzato – dati e condivisi, imposti sovente dalla legge del mercato pronta a sbaragliare gli incerti o i ritardatari…
La banca è un sistema dinamico, anche la banca di ieri lo era, seppure si mostrava talvolta somigliante ad un ministero: e il dinamismo era nei sensori territoriali ma non meno nella elasticità ricognitiva e programmatoria dei vertici, nel censimento delle opportunità accertate e di quelle magari soltanto alle viste. La stessa intelligenza puntata ad individuare aree di mercato da sostenere e altre da cui tempestivamente sganciarsi per non impoverire il patrimonio ed intaccare la missione della banca, quella stessa intelligenza volta a coordinare e promuovere talenti e propensioni presenti in organici importanti anche per dimensioni – fino a quattrocento unità nell’Isola – pareva accompagnare i percorsi dei personaggi delle pagine scritte. Nelle quali trovavi perfino lo stesso lessico e quasi lo stesso periodare che era dell’autore nelle sue vesti professionali.
Una storia unica
In quella filiale di casa Deffenu, sui margini del corso Garibaldi con tanta insistenza e genialità descritto da Salvatore Satta, Lui era entrato la prima volta nel 1949, vincitore brillante di concorso nazionale, provenendo dalle mansioni esercitate, prima della caduta del regime, come dattilografo e già fattorino-avanguardista alle dipendenze del camerata federale, anzi federale-comandante (perché ex-combattente con Franco in Spagna), dopo le fatiche di carica-casse (carichino-imballatore, poi anche pesatore ed etichettatore) nelle aziende dei Guiso Gallisai – la famiglia più cospicua di Nuoro e dell’intera Barbagia, e la più generosa non soltanto con il mulino-pastificio –, dopo i debutti infantili nelle cave granitiche di Cocorrovile ed il passaggio sulcitano…
A 24 anni, nel 1949 anno di molte svolte, poteva guardare a ritroso e scopriva che la sua vita era stata dieci volte più lunga di quanto quel quarto di secolo misurato dal calendario pareva mostrare. Perché ad annodare le picconate nelle cave di paese («sui blocchi già squadrati per ricavarne cantoni: dal mattino alla sera battevo sui ferri per fare buchi profondi nei quali venivano conficcati cunei d’acciaio, messi poi “in tira” da poderosi colpi di mazza») ed i cedimenti della schiena nell’impero dei Guiso Gallisai, c’era stata – l’ho detto – anche quell’altra pratica, pure essa più nell’adolescenza che nella giovinezza, di nuovo con le mine (tagliapietra scelto!), nella città tutta di uomini che s’era inaugurata nel 1938 per la gloria del duce del fascismo.
Lui tredici-quattordicenne in mezzo ad adulti, e il letto in un rustico tutto calce comunque da preferire alle baracche piene di cimici… Fino, appunto, al ritorno in Barbagia, non in paese ma a Nuoro adesso, e quasi per la prima volta: era di maggio, nella città che al tempo si presentava settorializzata, tutta frazionata, quasi infraghettizzata per provenienza dei suoi abitanti: come una federazione ora di mutue indifferenze ora di complicate relazioni fra mamoiadini e bittesi, orgolesi e fonnesi od orunesi… Qui il padre, tornato con una menomazione grave dalla missione armata nella Spagna in fiamme, aveva finalmente trovato posto alle dipendenze del Municipio e, giusto in faccia all’Ortobene, anche una casa con l’orto: un provvidenziale orto che aveva subito imparato a dare del suo alla tavola familiare d’ogni giorno e consentito poi pure un piccolo commercio, per il maggior respiro di grandi e piccoli.
Sì, l’ultimo tempo, dopo l’abbandono del pastificio, era stato più leggero in quanto a fatica fisica e certamente più fecondo in quanto ad accumulo di prospettive utili. Il desiderio di conoscere lo spingeva a memorizzare le espressioni di lingua ufficiale e burocratica, ma anche di lingua corrente, emigrando così dalle «asprezze» del suo dialetto e moderando – potenza della parola! – anche quella certa impulsività cresciuta col tempo e che aveva sconfitto l’originaria timidezza: lo aveva anche indotto ad inventarsi modi validi per passare il tempo ed imparare, sempre imparare: così la dattilo-scrittura, da autodidatta, negli uffici lasciati liberi, la domenica, dagli impiegati della Federazione delle camicie nere. Sullo sfondo una promessa di assunzione proprio come dattilografo, a Nuoro.
Vien da pensare qui a un altro uomo di banca, dirigente a Nuoro fin quasi alla pensione e collega di Bachisio Zizi impiegato-funzionario nelle anguste stanze del corso Garibaldi, in quegli anni fra ’50 e ’60, di povertà e anche di lavoro, di emigrazione e insieme però di iniziativa, nella nostra Isola in generale e nella provincia meno fortunata d’Italia: a quell’Antonino Campus entrato nelle cronache per il disgraziato sequestro di persona che subì nel 1975 senza che mai i colpevoli fossero individuati, a quell’Antonino Campus del quale proprio Bachisio Zizi – Zizi l’intellettuale – offrì pubblici riconoscimenti nel momento del ritiro, in lui indicando una sorta di alfiere magno della cultura del lavoro, dunque di quella esperienza che è capace di pareggiare ogni approdo conseguito invece ai grandi studi, alle università e magari ai master.
Perché anche Campus era partito avventizio, sedicenne appena, al Banco di Napoli – il teatro era Lanusei – nei primissimi anni ’40, tempo di guerra e di vuoti improvvisi negli organici aziendali per i richiami al fronte. Avventizio ausiliare, e poi aveva scalato – lavorando e lavorando, e studiando per il diploma e dopo per i concorsi interni – le categorie e le gerarchie dell’impiego. Zizi conosceva il valore dell’uomo, in quel suo coetaneo vedeva ben più che il collega: un altro se stesso, capace di ogni avanzamento per merito di impegno, di diligenza e dedizione, di lealtà all’Istituto, di socialità disinteressata.
Anni di guerra. Il padre scalpellino poi inserviente comunale (ma dall’età di sei anni servo pastore!), adesso carabiniere ad Orosei, Bachisio con i suoi sei fratelli a far cooperativa con la madre, ogni giorno guadagnandolo alla vita. A Nuoro un nuovo federale e il duce del fascismo nuovamente in città ad incoraggiare la popolazione ed a giurare che la guerra la si sarebbe vinta contro la perfida Albione nemica dai tempi della campagna etiopica e contro ogni altro nemico di qua e di là dell’oceano.
Il 1942, e la promozione a dattilografo. E poi la licenza d’avviamento e la scuola tecnica e poi l’istituto tecnico. Sarebbe venuta un giorno la facoltà di Scienze bancarie e la laurea solenne. In casa due pensionanti – studentesse delle Magistrali –, vite giovani a tavola anch’esse, insieme, la sera. E Cagliari, e non solo Cagliari, sotto i bombardamenti aerei. A Nuoro suonavano le sirene d’allarme, a rischio erano le polveriere di Pratosardo, e con Pratosardo a rischio era la città tutta… La fuga ad Orune, sfollamento dalla città che accoglieva gli sfollati… (quanti cagliaritani a Nuoro!). Un amore che sboccia, lo scambio di lettere a dare materialità al sentimento. Ancora promozioni a scuola, il sogno che affiora di un’iscrizione all’accademia navale… che rivoluzione mentale per un barbaricino!
Il 1943, la caduta del regime, finalmente, e però anche il licenziamento dalla decaduta, liquefatta Federazione dei Fasci di Combattimento, con un manganello di legno nero rimasto a presidio dell’ufficio morto. Giù, dai palazzotti della città, tutte le insegne che avevano cantato gli inni della dittatura. A scuola con quel ritardo imposto dalla vita difficile, e insieme le nuove scoperte della democrazia, del parlare libero, del parlare anche di Giordano Bruno e Galileo Galilei e De Sanctis. Un padre non più carabiniere, adesso calzolaio o impagliatore di sedie o tegolaio sui tetti, magari anche falegname, tutt’attorno il mercato nero…
Un amore comune: per il rettore Satta Musio
Delle sue vicende di vita capitava ne parlasse, Bachisio Zizi, anche se il più l’aveva già riversato sui libri. Almeno in quanto ai fatti. Tutti i libri che sono venuti nella fase più matura della sua biografia di narratore sono studi sull’esistenza, sono elaborazioni sempre più dotte sui perché del mondo. Fattosi semiologo per gusto e passione, i libri che Egli leggeva nelle lunghe ore della veglia quotidiana – ché confidava, umiliato, di non sapere più dormire, ormai da decenni! oltre le cinque ore – erano quelli degli antropologi, dei filosofi, dei linguisti… Levi Strauss, Roland Barthes, gli strutturalisti… E consigliava queste letture a quelli che lo frequentavano e, ricambiati, gli volevano bene.
Aveva imparato ad utilizzare il personal computer molto prima e molto meglio di tanti suoi giovani collaboratori, aveva fondato una casa editrice che non nascondeva le sue ambizioni anche di promozione dei talenti, s’era misurato con l’arte del documentarista televisivo…
Ad unirci ci aveva pensato molto il rettore Satta – Francesc’Angelo Satta Musio, rettore di Orvine-Orune – al quale Lui aveva dedicato il romanzo – primo della seconda e maggiore serie – “Il ponte di Marreri”, ed io, oltre vent’anni dopo, avevo offerto pagine biografiche e in contesto asproniano e in contesto massonico (per il mito eleonoriano che aveva conquistato le logge sarde negli anni ’60 e ’70 dell’Ottocento).
Lo scambio di carte, di documenti, di notizie intorno alla figura di quel parroco discusso e geniale, padrone del maggior podere agricolo (podere modello) del Nuorese, intimo del compaesano canonico divenuto deputato repubblicano e nemico acerrimo del vescovo Demartis fu intensissimo, frequente, abbondante. Saliva sopra ogni cosa la tensione pedagogica del prete, salivano quelle lezioni in limba sui sistemi di aratura e concimazione e varia agricoltura, quei testi mandati a memoria dai braccianti, saliva quell’utopia del cumone, della pacificazione fra agricoltori e pastori conseguente all’integrazione dei rispettivi interessi. Saliva il suo liberalismo ideologico – lui che diceva messa comunque, e se ateismo era il suo non lo era di meno quello dei clericali più occhiuti a presidio, allora, di Santa Maria della Neve – e amava il tricolore della patria italiana.
Gianfranco Murtas



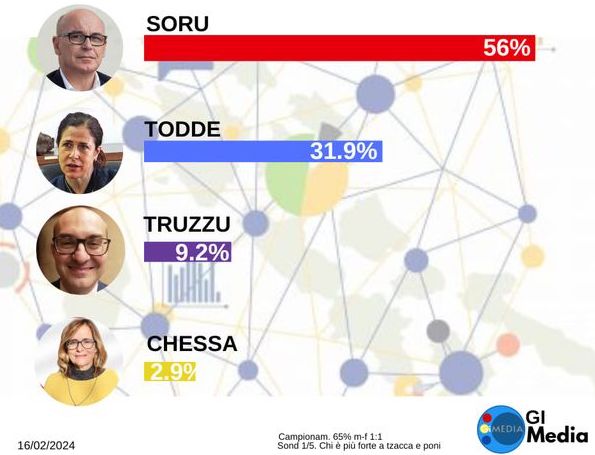


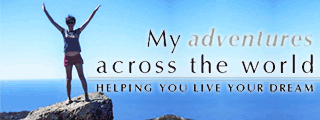

Ultimi commenti